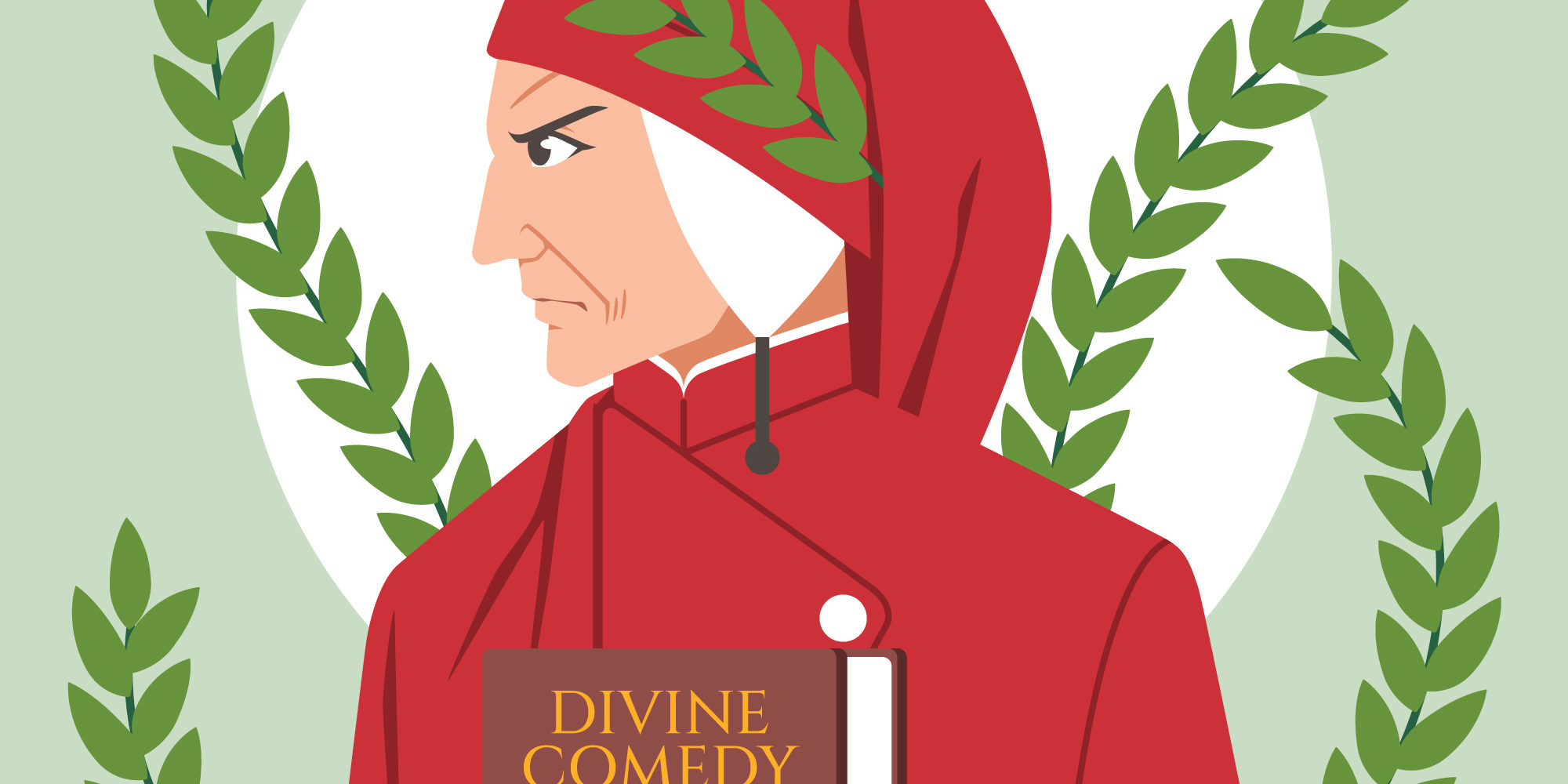Nel 1861 la lingua di Dante era quasi sconosciuta tra gli abitanti della Penisola. Ci sono voluti decenni perché poco alla volta si imponesse come idioma nazionale comune
C’è un filo conduttore che unisce una legge del 1859, Alessandro Manzoni, la guerra in trincea e la televisione pubblica: è la diffusione della lingua italiana nella Penisola, che ha seguito un percorso davvero particolare.
Al momento dell’Unità, nel 1861, l’italiano era parlato da una minoranza della popolazione, circa il 2-3% del totale. Un ulteriore ostacolo alla sua diffusione era rappresentato dall’analfabetismo, che era altissimo: circa il 78% della popolazione di età superiore ai sei anni non sapeva né leggere né scrivere. La stragrande maggioranza degli italiani comunicava attraverso dialetti locali, spesso molto diversi tra loro, e per gli stessi “Padri della Patria” come Cavour, re Vittorio Emanuele II e Garibaldi l’italiano era una “seconda lingua”. Il primo scriveva e parlava soprattutto francese e usava l’italiano per lo più in contesti formali, politici o negli scritti (come discorsi pubblici e atti ufficiali). Vittorio Emanuele II usava prevalentemente il piemontese, spesso in una forma popolare e colorita e aveva una scarsa padronanza dell’italiano, tanto che nei documenti ufficiali spesso si faceva aiutare dai segretari. Giuseppe Garibaldi parlava un dialetto ligure-nizzardo, oggi quasi scomparso, e la sua competenza nell’italiano scritto era piuttosto limitata.
Sono tanti gli eventi chiave che hanno portato alla diffusione dell’italiano in questi oltre 160 anni di storia nazionale, a partire dalla Legge Casati, emanata nel 1859 dal Regno di Sardegna e poi estesa al Regno d’Italia nel 1861. Si tratta della prima legge organica sull’istruzione pubblica in Italia, che introduce l’obbligo di frequentare almeno il primo biennio della scuola elementare e impone l’italiano come lingua di insegnamento. Anche letteratura giocò un ruolo fondamentale: fino a quel momento l’italiano era una lingua scritta, usata da una minoranza colta. Alessandro Manzoni riteneva invece necessario “fare gli italiani anche attraverso la lingua” e ne cercava una viva, moderna, comprensibile, non solo letteraria. Il suo contributo alla diffusione e alla standardizzazione dell’italiano è fondamentale, soprattutto per il ruolo che ebbero “I Promessi Sposi”, la cui lingua influenzò profondamente la scuola e la letteratura del nuovo Regno d’Italia.
Anche il servizio militare obbligatorio, mettendo a contatto giovani di diverse regioni, contribuì all’adozione di una lingua comune, spesso usata in forma semplificata. In questo ambito uno spartiacque fu la Prima Guerra Mondiale. «La lontananza dalle proprie famiglie e dal proprio luogo di vita, i patimenti della trincea o della prigionia, il costante pensiero rivolto alla morte fecero sentire alla massa dei soldati il dramma della solitudine linguistica – scrive sul sito dell’Accademia della Crusca il linguista Francesco Sabatini. Si avvertì allora acutamente da parte loro, com’era stato per le schiere di emigrati, il bisogno di conquistare, insieme con l’italiano, l’uso della scrittura».
L’ultima grande ondata di diffusione dell’italiano tra gli italiani è legata alla nascita della televisione pubblica. A partire dagli anni Cinquanta, la Rai promuove una versione standardizzata della lingua con una pronuncia chiara e codificata, priva di inflessioni dialettali, per essere compresa da tutti. Grazie alla televisione, le famiglie italiane vengono “immerse” nell’italiano, consolidandolo come lingua d’uso quotidiano. «La televisione italiana, almeno nei primi decenni, fu uno straordinario strumento di unificazione linguistica – ha scritto Umberto Eco – Ha insegnato l’italiano a un popolo che parlava ancora prevalentemente dialetto».